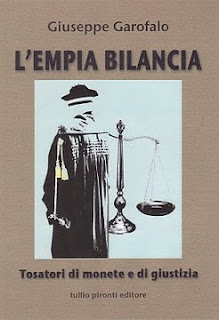Il 1744, l'anno in cui Gennaro e Vincenzo Muzio, pubblici Padroni di Stampa nella Fedelissima Città di Napoli, pubblicano i Principi di Scienza Nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni del Signor Don Giambattista Vico, regio professore di Retorica nello Studium napoletano, l'attuale Università "Federico II". Sono trascorsi quasi cento anni da quando Tommaso Cornelio aveva portato a Napoli le opere di Cartesio, ma anche di Spinoza, Gassendi, Hobbes, Leibnitz e altri. La filosofia cartesiana, e tutto ciò che da essa derivava (polemiche vivacissime, perfino duelli tra i membri delle Accademie, allora numerosissime, tant'è che il Vicerè era stato costretto a chiuderle per motivi, diremmo oggi, di ordine pubblico), aveva "favorito il risveglio delle coscienze, il rinnovamento della cultura e la messa in discussione di valori sui quali erano stati basati i tanti privilegi degli ordini religiosi; aveva "insegnato attraverso lo strumento dell'istruzione nuovi modi di fare ricerca scientifica in forme organizzative nuove", e per mezzo della collaborazione e lo scambio di scienziati e filosofi aveva "consentito di rompere l'isolamento nel quale Napoli versava, favorendo i collegamenti con i maggiori centri di ricerca in Europa" (G. Belgioioso). Insomma un fenomeno culturale e scientifico di portata non misurabile, che ancora un secolo dopo aveva ricadute politiche, mentre il giurisdizionalismo metteva in discussione il monopolio dei "conventi" sull'istruzione e soprattutto il sistema feudale. In questa temperie culturale e politica si svolge il processo contro Gaspare Starace, cassiere maggiore del Banco dello Spirito Santo di Napoli, arrestato il 16 ottobre 1744 nella sua abitazione di via Toledo, annessa ai locali del Banco, essendo stato accusato d'avere smerciato monete d'oro, in particolare zecchini veneziani "tosati", ossia scarsi di peso, di uso di bilance e pesi truccati, abusivo esercizio di finanziamento. In termini giudiziari, per il reato di falsità in moneta, genericamente detto "reato monetario", punibile con la pena capitale. Il tema del processo contro Starace è l'argomento del ponderoso e poderoso saggio di Giuseppe Garofalo “L'empia bilancia”. Tosatori di monete e di giustizia (Tullio Pironti Editore, Napoli 2010, pp. 508, E. 18,00). L'Autore, principe del Foro, storico avveduto e saggista acutissimo, affondando il bisturi dell'analisi nei documenti (non soltanto quelli processuali, bensì anche politici e civili), tenta, riuscendovi pienamente, di "rileggere" in chiave diacronica e sincronica il problema dell'amministrazione della Giustizia. Una folla impressionante di personaggi compare sul palcoscenico di Castel Capuano, secolare teatro di giustizia del Viceregno: re Carlo di Borbone, il governatore Gioacchino Montealegre, duca di Salas, il Guardasigilli - con espressione attuale - marchese Don Bernardo Tanucci, al quale va il merito d'avere imposto, primo in Europa, l'obbligo di motivare le sentenze, fino ad allora arcana juris, e in quanto tali veri e propri strumenti di potere e d'arbitrio; giudici, avvocati di grido padroni d'un bagaglio culturale di dimensione europea e "paglietti", un esercito, come scrisse l'Abate Ferdinando Galiani, d'individui ignoranti, affaristi, corrotti, famelici; testimoni, investigatori, carcerieri, delatori, collaboratori di giustizia ante litteram. Quello stesso Abate che nell'opera (invero pubblicata adèspota, ossia sotto forma anonima) intitolata “Della moneta” aveva trattato della tosatura delle monete e dell'organizzazione dei Banchi pubblici napoletani con acutezza e rigore teorico: due argomenti che l'avv. Franco aveva largamente sviluppato nella sua "allegazione" in difesa dello Starace. Amara è la constatazione di Garofalo a proposito della prammatica tanucciana, dalla vita purtroppo brevissima, essendo prima caduta per disapplicazione poi formalmente abolita quando a Palazzo non c'era più il marchese fiorentino, ma la regina Maria Carolina che lo detestava ferocemente: "Lo scontro per la motivazione delle sentenze era stata una lotta tra ingenui: Tanucci pensava che con la motivazione sarebbe scomparso l'arbitrio dei giudici, i giudici pensavano che con la motivazione l'avrebbero perduto. La Storia ha dimostrato il contrario. Al posto delle decisioni arbitrarie sono succedute le motivazioni arbitrarie a sostegno di decisioni conseguentemente arbitrarie. Peggio ancora. Sono comparse anche motivazioni suicide, scritte col chiaro proposito di provocare l'annullamento della decisione". Non è, tuttavia, soltanto questo, tra le vicende del processo contro Starace svoltosi in quegli anni vertiginosi, a catturare l'attenzione indagatrice dell'Autore, bensì il generale discredito entro cui era immersa la giustizia. Un discredito che aveva provocato la contestazione di pensatori e scrittori insigni, tra i quali Giuseppe Aurelio Di Gennaro, giureconsulto ed erudito, che aveva dato alle stampe (per i tipi del medesimo Stampatore di Vico, e nello stesso anno in cui comparve la Scienza Nuova) un'opera che riscosse immediato e clamoroso successo in Europa, tant'è che in breve tempo venne tradotta in francese e in inglese, “Delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro”; e il modenese Ludovico Antonio Muratori, grande storico, letterato ed erudito di straordinaria capacità e tenacia, estraneo, e per motivi ideologici e per l'ispirazione cattolica della sua dottrina, alla cultura dell'Illuminismo, epperò anticipatore di alcuni fra i più frequenti motivi dell'illuminismo giuridico italiano, il quale con il suo trattato De' difetti della Giurisprudenza (1742) aveva rivolto una critica sistematica al diritto comune, sradicando l'idea stessa di diritto "comune", ossia di diritto valido, secondo la concezione medioevale, per tutto l'Impero inteso come tutto il diritto civile (Fassò). Tra i "difetti intrinseci della giurisprudenza e della giudicatura", "l'essere tali le leggi che non proveggono, né possono provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti". A ciò s'aggiunga il difetto dell'interpretazione, per cui si è "riempiuta la scuola della giurisprudenza d'incertezza". Altro trafiggente argomento, questo, su cui Giuseppe Garofalo svolge un'indagine comparativa tra la giustizia di ieri e quella d'oggi. Non è dato in una, per necessità breve, recensione, dar conto di tutti i temi che l'insigne Autore analizza, - come detto avanti, in chiave diacronica e sincronica -, "rileggendo" gli atti del processo contro il cassiere maggiore del Banco dello Spirito Santo di Napoli e rivisitando con assoluta acribia scientifica la storia "evenemenziale". Soltanto posso dire che dall'opera dell'avvocato Garofalo, il Settecento che viene trasmesso al lettore non è più soltanto il secolo di Goldoni, di Alfieri, Parini, ma è, forse soprattutto, il secolo di Pietro Verri, di Antonio Genovesi, di Ferdinando Galiani, di Gaetano Filangieri, di Pietro Giannone, di Giambattista Vico, il "divino napoletano", protagonisti e partecipi d'un complessa attività e volontà di cambiamento. Quel cambiamento che ancora nei giorni nostri non s'è verificato! Insomma, per concludere, aggiungo che la lettura de L'empia bilancia. Tosatori di monete e di giustizia, caratterizzato tra l'altro da un'accattivante prosa e da una sottile vena ironica, offre al giurista e all'uomo politico l'occasione per rimeditare ancora e in profondità sul grande, irresoluto problema della giustizia.